All’interno di Anni Luce, l’osservatorio sugli artisti emergenti organizzato dal Romaeuropa Festival, debutta La Classe, ultimo lavoro di Fabiana Iacozzilli.
Coprodotto con CrAnPi, La Fabbrica, il Teatro Vascello e Carrozzerie | not, il docupuppet (così viene presentato) è un passo avanti nella ricerca della Iacozzilli, che approfondisce la sua poetica legata a un immaginario trasfigurato, favolistico e grottesco. Questa volta i protagonisti
 sono delle marionette, eleganti, tenere, commoventi pupazzi di legno e pezza, (costruiti artigianalmente dalla scenografa Fiammetta Mandich) che, come dice la regista, sono “un approdo quasi naturale” del suo percorso registico.
sono delle marionette, eleganti, tenere, commoventi pupazzi di legno e pezza, (costruiti artigianalmente dalla scenografa Fiammetta Mandich) che, come dice la regista, sono “un approdo quasi naturale” del suo percorso registico.
In una riedizione della memoria, dove i ricordi dei compagni di classe della regista in puro stile audiodoc si mescolano alle scene dei puppet, viene ricostruito fantasmagoricamente il rapporto di puro terrore tra quattro bambini e la loro ferocissima maestra, una suora impersonata da una voce, un corpo nero e un sigaro fumante.
Le marionette, con i loro volti assenti, ma distinte da caratteri, movenze, tic e personalità sembrano coprire uno spettro tanto ampio da comprendere l’infanzia intera, con tutti i suoi incubi e desideri, facendo esplodere la libertà di proiettare la propria vita e rendendo inevitabile e fortissima l’immedesimazione. Tra compiti, temini, interrogazioni e disegni, i quattro ragazzini mostrano una fragilità collettiva delicata come le ginocchia sbucciate e immergono gli spettatori in un magma indistinto dove il dato biografico più personale diventa un inquietante dolore universale.
 La forma del docupuppet non permette però solo l’affastellamento della memoria storica sulla rappresentazione, ma si sviluppa in una pluralità di piani mostrando la macchina registica che dall’oscurità della scena esce alla luce. Gli attori che muovono le marionette, le scene, le luci e gli oggetti con un’esattezza chirurgica (in scena Michela Aiello, Andrei Balan, Antonia D’Amore, Francesco Meloni, Marta Meneghetti), non sono meri esecutori, ma parte integrante del racconto: con quell’infanzia fragile infatti hanno un rapporto, l’aiutano, la coccolano e ne vengono ricompensati con gesti che nella loro piccolezza esplodono d’amore.
La forma del docupuppet non permette però solo l’affastellamento della memoria storica sulla rappresentazione, ma si sviluppa in una pluralità di piani mostrando la macchina registica che dall’oscurità della scena esce alla luce. Gli attori che muovono le marionette, le scene, le luci e gli oggetti con un’esattezza chirurgica (in scena Michela Aiello, Andrei Balan, Antonia D’Amore, Francesco Meloni, Marta Meneghetti), non sono meri esecutori, ma parte integrante del racconto: con quell’infanzia fragile infatti hanno un rapporto, l’aiutano, la coccolano e ne vengono ricompensati con gesti che nella loro piccolezza esplodono d’amore.
In questa iperproduzione macchinica che l’infanzia della regista sembra rigurgitare sul palco, le suggestive scenografie cambiano continuamente le prospettive e gli equilibri dei piccoli protagonisti. Un gioco fatto di dimensioni precise immerse in un’instabilità costante, uno spazio dai suoni alterati che disarticolano vorticosamente le proporzioni come fa la memoria stessa, come continua a fare su ognuno di noi l’impronta della nostra età più lontana.
A coronamento di questa sovrabbondanza di piani che continuamente s’intersecano è la decisa rottura della quarta parete, con la regista stessa che irrompe nella storia. I suoi ricordi si fanno corpo, il dato biografico si fa esperienza del presente, ed è proprio in questa presa della scena che tutto si trasfigura ancora. Quello che sembrava solo uno struggente affresco su un tempo che ci ha inciso profondamente, diventa un rilancio di possibilità: “Non si sfugge dalla propria infanzia, ma dipende cosa ne si fa”, viene detto. E il trauma sublimato schizza nelle sue derive creative grazie a uno tra i ricordi più struggenti della tenebrosa maestra, un consiglio, una proposta, un inaspettato aiuto per diventare finalmente sé stessi: cerca un segreto dentro di te, chiudi gli occhi e lasciati trasportare.


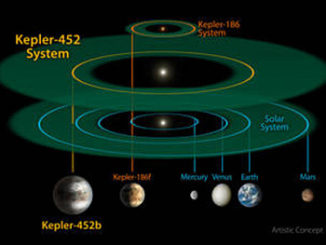


Commenta per primo