 di CLAUDIO BARBERIS*/ L’autunno del 2002 rappresentò per i paesi emergenti la nascita di un boom che sarebbe durato oltre una decina d’anni. Il Brasile stava eleggendo Lula come nuovo presidente e i mercati prezzavano uno scenario molto negativo come conseguenza di questa elezione: Lula guidava il Partito dei Lavoratori, era il candidato che più lontano si potesse pensare da Wall Street e anche nella retorica elettorale sembrava non interessato a corteggiare i mercati internazionali. Gli investitori da parte loro avevano ancora le ferite aperte della crisi argentina del 2000-2001 e pochi avevano dimenticato le crisi degli anni ’90, quando il Brasile (1994), il Messico (1994/95), l’area asiatica (1997), la Russia (1998)… portarono contagio e tensioni sui mercati di tutto il mondo.
di CLAUDIO BARBERIS*/ L’autunno del 2002 rappresentò per i paesi emergenti la nascita di un boom che sarebbe durato oltre una decina d’anni. Il Brasile stava eleggendo Lula come nuovo presidente e i mercati prezzavano uno scenario molto negativo come conseguenza di questa elezione: Lula guidava il Partito dei Lavoratori, era il candidato che più lontano si potesse pensare da Wall Street e anche nella retorica elettorale sembrava non interessato a corteggiare i mercati internazionali. Gli investitori da parte loro avevano ancora le ferite aperte della crisi argentina del 2000-2001 e pochi avevano dimenticato le crisi degli anni ’90, quando il Brasile (1994), il Messico (1994/95), l’area asiatica (1997), la Russia (1998)… portarono contagio e tensioni sui mercati di tutto il mondo.
Tra le cause di queste frequenti crisi vi era anche il sistema di tassi di cambio fisso con il dollaro adottato da molti paesi. Ancorando le valute locali al dollaro, i paesi emergenti ottenevano minor inflazione e più facile accesso ai mercati internazionali, sia finanziari sia delle merci. L’accesso ai mercati globali facilitava anche l’emissione di debito in valuta forte. Il cambio fisso non permetteva però una gestione proattiva della politica monetaria, cosicché periodicamente per via di recessioni o questioni (geo)politiche questi paesi si trovavano costretti a svalutare e non sempre riuscivano a rimborsare debiti in dollari diventati troppo costosi. L’acquisto di debito denominato in dollari dava in apparenza maggior tranquillità agli investitori internazionali: si rischiava il default, se lo stato emittente non fosse riuscito a rimborsare il titolo, ma in assenza di default si incassava un elevato spread e non si subiva la volatilità delle valute locali.
Dopo gli anni ’90, la crescita di queste economie e un diverso approccio alla gestione monetaria si tradussero nella scelta di tassi di cambio flessibili ed emissioni di debito in valuta locale per molti paesi. Cambi flessibili permettevano maggior spazio d’azione per la politica monetaria e l’emissione di debito in valuta locale si traduceva in minor rischio di default: nel caso di crisi, parte delle perdite per gli investitori internazionali non si traduceva in un default repentino ma in un deprezzamento delle valute. Un deprezzamento delle valute era comunque una perdita, ma meno drammatica e complessa da gestire di un default.
Cambi flessibili ed emissione di debito in valute locali hanno anche permesso di trasferire parte del rischio valutario dai governi agli investitori internazionali. Questa evoluzione avvenuta dopo le crisi degli anni ’90 ha riguardato molti paesi ed è stata possibile grazie ad una fase di forte crescita di queste economie e di grande interesse da parte degli investitori internazionali, spesso afflitti da tassi bassi nei loro paesi e attratti dal boom dell’area emergente. I buoni risultati ottenuti dall’amministrazione Lula in Brasile, la crescita asiatica e della Russa furono un forte incentivo alla progressiva affermazione di questo nuovo paradigma di cambi più flessibili e di coinvolgimento dei grandi fondi globali sulle piazze locali.
Questo boom durato oltre dieci anni ha visto un enorme flusso d’investimenti diretti e di portafoglio su questi paesi, nonché la nascita di una quantità di prodotti finanziari legati a questo tema. Si può oggi investire in modo indifferenziato su tutti questi paesi, oppure solo sui maggiori (Brasile Russi India Cina SudAfrica), sulle nuove promesse (Messico Indonesia Nigeria Turchia) o sui paesi di frontiera. L’investimento può essere fatto in debito in valuta forte o locale, in titoli di stato o societari, in azioni e in obbligazioni convertibili. Si tratta ormai di una asset class a tutto tondo che offre buona liquidità e tutte le gradazioni di rischio tipiche dei mercati evoluti, ampiamente accessibile anche all’investitore retail.
La crisi di questi giorni rappresenta la fine di questo boom decennale, è dolorosa per gli investitori e potrà ancora continuare, ma non deve essere vista troppo negativamente. La Cina è uno di quei paesi con un tasso di cambio ancora gestito dalla Banca Centrale, solo parzialmente flessibile. La svalutazione di questi giorni è qualcosa che in parte ricorda gli anni ’90: invece di un progressivo deprezzamento del cambio successivo al rallentamento dell’economia Cinese, il cambio è stato tenuto stabile e solo all’ultimo svalutato, creando tensione sui mercati forse maggiore di quella che si sarebbe avuta con un lento deprezzamento.
Il recente deprezzamento delle valute dei paesi emergenti flessibili e la svalutazione di quelle a cambi controllati rappresenta la normale dinamica di mercato che ci si aspetta quando un’economia entra in una fase di debolezza rispetto ad un’altra: il suo tasso di cambio si indebolisce creando le condizioni per una maggior competitività e quindi per una ripresa.
I tassi di cambio flessibili permettono oggi alle economie emergenti di reagire a fasi di debolezza molto più di quanto riuscissero a fare negli anni ’90. Permettono loro di spostare parte del rischio di mercato ed economico agli investitori internazionali. Nonostante la forte volatilità di questi giorni e il fatto che con questi cali i mercati emergenti stanno in parte annullando il vantaggio di performance accumulato negli anni del boom, quella dei mercati emergenti è una asset class oggi matura e talmente evoluta che non si può pensare ad una involuzione totale di questo trend.
La volatilità delle valute è un problema per gli investitori nel breve periodo, ma è anche una tutela per alcuni paesi che con i cambi fissi degli anni ’90 adesso starebbero già defaultando con conseguenze ancora peggiori per l’economia globale, considerando quanto pesano oggi le economie emergenti rispetto al ruolo marginale che avevano allora.
* Claudio Barberis, head of asset allocation di MoneyFarm SIM


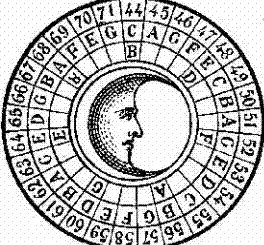

Commenta per primo